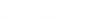Isole Cook: il paradiso sconosciuto.

Meno note, e meno costose, delle cugine tahitiane, le Cook sanno regalare autenticità e incontri speciali. Con lagune straordinarie, isole vulcaniche, sciamani ed esperti di questa natura forte ed esuberante. Tutelata in una grande riserva marina e in un piano governativo di sviluppo sostenibile
 Ho sempre diffidato del paradiso. Termine usato e abusato, poiché troppi sono i paradisi turistici che riempiono pagine e pagine di guide e riviste. Luoghi dell’anima in vendita, spacciati come “incontaminati”, non inflazionati da turisti in infradito (perché il paradiso è sempre quello con il mare cristallino, le palme reclinanti, gli alberi carichi di frutti e i pesci a portata di mano). Luoghi cristallizzati nella loro perfezione da cartolina, qualcosa che esiste non in virtù di ciò che è ma per quello che rappresenta, un’eterna promessa di felicità e giovinezza, dove ritrovare se stessi lontano dalle brutture e dalle disarmonie della quotidianità. Un altrove e un diverso pieno di cliché e di stereotipi, che vorremo imporre a coloro che vivono in un Eden che consideriamo di nostra proprietà, abitato da indigeni felici, gentili e ingenui con gonnellini di palma sotto capannucce afose, ma anche da aria condizionata e frigobar pieni per turisti distratti. Pure immagini, senza uno ieri e un domani, nutrite solo di un oggi e di un qui, la cui lontananza è garanzia di pace e bellezza. Paesaggi per un mondo che non desidera altro che essere sedotto, isole da ammirare, ma non vivere, in una visione orizzontale, panoramica, che non può e non vuole andare a fondo, calandosi in una realtà che rischia di deludere. Il tutto marchiato da un lusso uguale in tutto il mondo: cucina internazionale, pulizia impeccabile, lenzuola di lino, stuoli di camerieri. Anche le Cook, nelle cui acque danzano le balene, sono un paradiso, ma che non mette soggezione, da vivere fino in fondo. Con un lusso a tratti ruvido, non patinato e impermeabile, che non isola dal contesto nel quale è nato. Dove nel giardino del resort puoi vedere ruzzare una gallina con i suoi pulcini e la massaggiatrice arriva dopo una partita di cricket, ancora con la maglietta della propria squadra addosso. Perché le Cook hanno ancora quello che altri posti omologati dal turismo e dal lusso hanno perso: l’anima. Un pugno di isole gettate nel Pacifico, autentiche, vere, dove i fiori, splendidi, appassiscono. Isole pacate e forti, dalla bellezza non languida e seduttiva ma semplice e rustica, dove bere la vita a pieni polmoni e desiderare di essere migliore per sembrare degni di tanta bellezza. Qui, dove le vahinè non hanno la flessuosità delle tahitiane ma l’opulenza delle matrone, il paradiso devi conquistartelo, confrontandoti con una natura esuberante, talvolta invadente, e qualche disagio. Lavorando non in termini di accrescimento di servizi e di orpelli ma di ritorno all’essenzialità, a una bellezza pura, non raggelata e raggelante, vissuta all’insegna della normalità.
Ho sempre diffidato del paradiso. Termine usato e abusato, poiché troppi sono i paradisi turistici che riempiono pagine e pagine di guide e riviste. Luoghi dell’anima in vendita, spacciati come “incontaminati”, non inflazionati da turisti in infradito (perché il paradiso è sempre quello con il mare cristallino, le palme reclinanti, gli alberi carichi di frutti e i pesci a portata di mano). Luoghi cristallizzati nella loro perfezione da cartolina, qualcosa che esiste non in virtù di ciò che è ma per quello che rappresenta, un’eterna promessa di felicità e giovinezza, dove ritrovare se stessi lontano dalle brutture e dalle disarmonie della quotidianità. Un altrove e un diverso pieno di cliché e di stereotipi, che vorremo imporre a coloro che vivono in un Eden che consideriamo di nostra proprietà, abitato da indigeni felici, gentili e ingenui con gonnellini di palma sotto capannucce afose, ma anche da aria condizionata e frigobar pieni per turisti distratti. Pure immagini, senza uno ieri e un domani, nutrite solo di un oggi e di un qui, la cui lontananza è garanzia di pace e bellezza. Paesaggi per un mondo che non desidera altro che essere sedotto, isole da ammirare, ma non vivere, in una visione orizzontale, panoramica, che non può e non vuole andare a fondo, calandosi in una realtà che rischia di deludere. Il tutto marchiato da un lusso uguale in tutto il mondo: cucina internazionale, pulizia impeccabile, lenzuola di lino, stuoli di camerieri. Anche le Cook, nelle cui acque danzano le balene, sono un paradiso, ma che non mette soggezione, da vivere fino in fondo. Con un lusso a tratti ruvido, non patinato e impermeabile, che non isola dal contesto nel quale è nato. Dove nel giardino del resort puoi vedere ruzzare una gallina con i suoi pulcini e la massaggiatrice arriva dopo una partita di cricket, ancora con la maglietta della propria squadra addosso. Perché le Cook hanno ancora quello che altri posti omologati dal turismo e dal lusso hanno perso: l’anima. Un pugno di isole gettate nel Pacifico, autentiche, vere, dove i fiori, splendidi, appassiscono. Isole pacate e forti, dalla bellezza non languida e seduttiva ma semplice e rustica, dove bere la vita a pieni polmoni e desiderare di essere migliore per sembrare degni di tanta bellezza. Qui, dove le vahinè non hanno la flessuosità delle tahitiane ma l’opulenza delle matrone, il paradiso devi conquistartelo, confrontandoti con una natura esuberante, talvolta invadente, e qualche disagio. Lavorando non in termini di accrescimento di servizi e di orpelli ma di ritorno all’essenzialità, a una bellezza pura, non raggelata e raggelante, vissuta all’insegna della normalità.
Una natura che non regala nulla
 Qui la natura promette ma non regala nulla, ricca e forte, sincera e matrigna, ti sorprende per la sua luce purissima, le chiesette dal candore accecante, i tramonti preziosi intessuti d’oro, il richiamo languido del mare che imprigiona e conforta, unisce e divide. In un mondo dominato dalla ricerca dello straordinario, offrono autenticità e la possibilità di un viaggio che si trasforma realmente in un’esperienza. Perché un viaggio non è un prodotto turistico, una collezione di luoghi. È verità, è una storia di incontri. Con luoghi e con persone. Imponenti, solidi, gli abitanti delle Cook convivono con l’oceano che morde le rocce coralline, i lampi di luce dei tonni che guizzano fra le onde, le stradine ossute mangiate dalla sabbia e dal sole, l’ombra ristoratrice delle foreste, l’orizzonte spezzato da vulcani aguzzi e accartocciato dal fiato dell’estate.
Qui la natura promette ma non regala nulla, ricca e forte, sincera e matrigna, ti sorprende per la sua luce purissima, le chiesette dal candore accecante, i tramonti preziosi intessuti d’oro, il richiamo languido del mare che imprigiona e conforta, unisce e divide. In un mondo dominato dalla ricerca dello straordinario, offrono autenticità e la possibilità di un viaggio che si trasforma realmente in un’esperienza. Perché un viaggio non è un prodotto turistico, una collezione di luoghi. È verità, è una storia di incontri. Con luoghi e con persone. Imponenti, solidi, gli abitanti delle Cook convivono con l’oceano che morde le rocce coralline, i lampi di luce dei tonni che guizzano fra le onde, le stradine ossute mangiate dalla sabbia e dal sole, l’ombra ristoratrice delle foreste, l’orizzonte spezzato da vulcani aguzzi e accartocciato dal fiato dell’estate.
Qui dove uomini e tradizioni, vita sociale e religione sono una cosa sola, i ritmi sono regolati dalla pesca, terza risorsa del Paese dopo il turismo e le banche off-shore, e dalla Chiesa. Oggi come nel 1821, quando giunsero i missionari della London Missionary Society. Bruciati gli idoli, aboliti danze, tatuaggi e poligamia (ma anche il cannibalismo), imprigionata la sensualità femminile in ampie vesti e mortificata l’innocenza di un popolo instillando in lui il senso del peccato, con l’aiuto dei capi locali, gli ariki, esercitarono un forte controllo sociale grazie al Blue Laws: la domenica il cibo doveva essere cucinato la mattina, nessuno poteva camminare per le strade eccetto che per visitare un ammalato, cercare riparo a un uragano, recuperare un maiale in procinto di morire o una canoa in balia delle onde. Con gli europei arrivarono anche le malattie che decimarono i polinesiani, tanto che Rarotonga nel 1880 scese da 7mila a 2mila abitanti. A completare l’opera furono alcuni schiavisti peruviani, che reclutarono migliaia di persone facendo credere loro che sarebbero andate a lavorare in un’isola vicino all’equatore, portandole invece a morire nelle miniere peruviane di guano di Callao. In questo aiutati dagli stessi missionari, speranzosi che il benessere promesso avrebbe favorito la costruzione delle chiese. Quelle chiese che sole sembrano avere dignità di architettura, punteggiando con i loro tetti aguzzi atolli e isolette, uniche a imporsi per verticalità in un paesaggio fatto solo di alberi e arbusti e casette colorate fronteggiate dalle tombe degli antenati.
Articolo di Isabella Brega per Touring Magazine